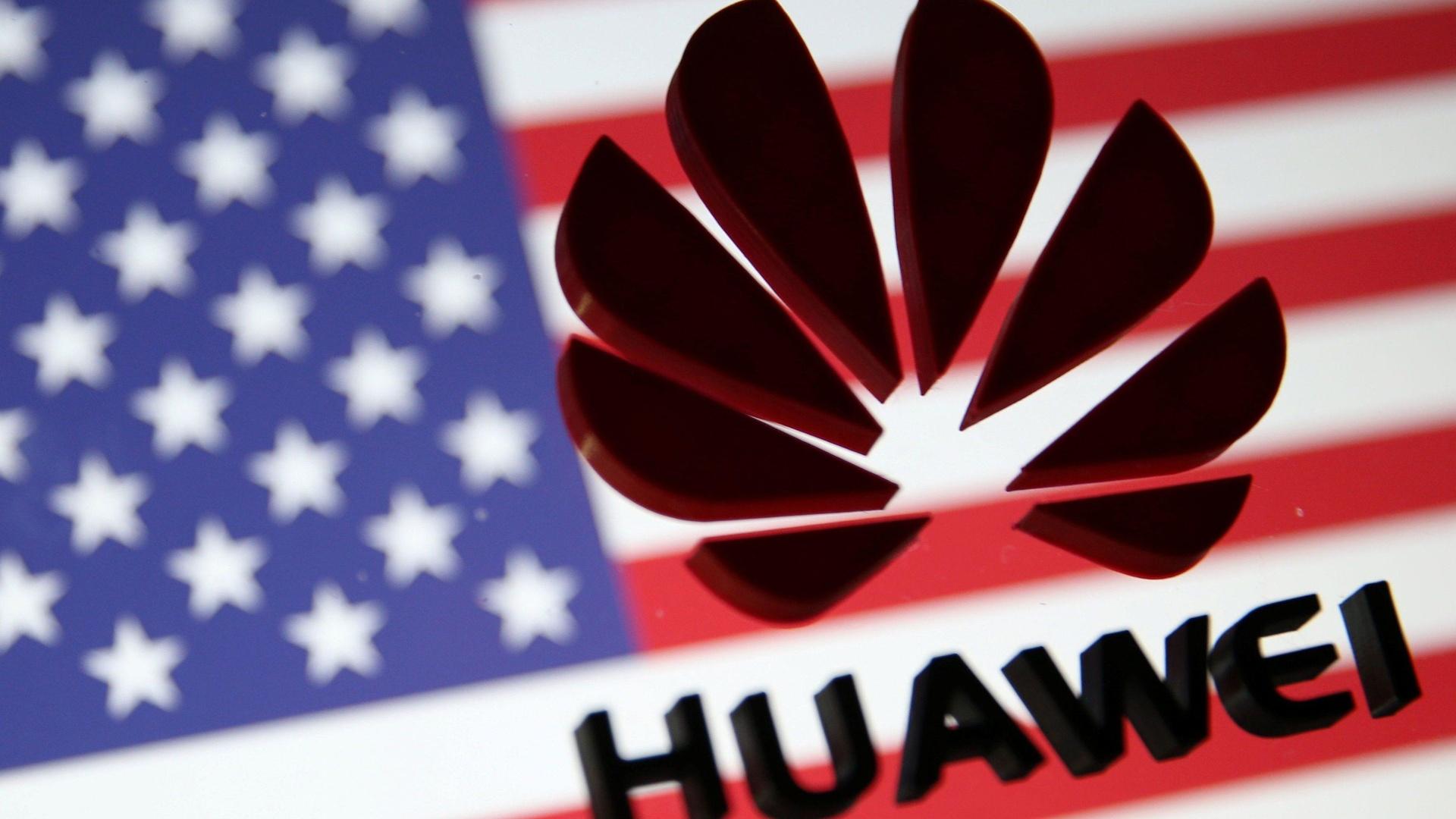Il caso Huawei e la guerra tecnologico-commerciale tra USA e Cina
Lunedì 28 gennaio, i vertici delle istituzioni giudiziarie e di sicurezza degli USA hanno formalmente richiesto al Canada l’estradizione di Meng Wanzhou. La direttrice finanziaria di Huawei, figlia del fondatore e presidente Ren Zehngfei, era stata arrestata su loro istanza, mentre faceva scalo all’aeroporto di Vancouver, all’inizio di dicembre. Su di lei pendono 23 capi di accusa, tra cui furto di segreti commerciali e tecnologici, riciclaggio, frode bancaria ed elusione delle sanzioni imposte all’Iran.
La vicenda ha suscitato forti tensioni ed è diventata un caso diplomatico che, innescato il principio di reciprocità, ha portato ad un gioco di ritorsioni giudiziarie.
Nelle ultime settimane, infatti, hanno avuto risalto internazionale una serie di procedimenti giudiziari condotti dalla Cina contro cittadini canadesi. La più nota è quella di Robert Schellenberg, già condannato in primo grado a 16 anni di reclusione per traffico di stupefacenti e rimandato dalla corte d’appello al primo grado del processo con la possibilità di una condanna a morte. Il cambio di pena è stato proposto in assenza di nuove prove dell’accusa, nonostante le norme cinesi lo vietino in simili circostanze. Oltre a ciò, dopo un primo grado condotto con una lentezza estranea al sistema giudiziario della Repubblica Popolare Cinese (RPC), il proseguo dell’iter processuale ha subito una forte accelerazione, evolvendosi in contemporanea alla vicenda della manager trattenuta in Canada.
Le vicende giudiziarie sembrano mettere in evidenza uno scontro di più ampio respiro, che si inserisce in quello scontro politico tra Cina e Stati Uniti che ha ora la sua espressione più forte nel contesto della guerra commerciale.
Dal 2018, infatti, Washington ha indetto dazi al 10% sulle importazioni di varie categorie di beni cinesi corrispondenti complessivamente a 250 miliardi di dollari. La motivazione ufficiale è stata la necessità di prendere contromisure per ridurre il disavanzo commerciale della Cina nei confronti del rivale statunitense, attestatosi nel 2017 a 375 miliardi di dollari. Inoltre, le barriere commerciali sarebbero state una leva per spingere il governo di Pechino ad attuare il principio di reciprocità negli scambi commerciali. Tuttavia, la virata protezionistica di Washington sembra affondare le proprie radici non solo in motivazioni di natura economica ma anche in una competizioni di natura strategica tra i due poli opposti del Pacifico. Infatti, i dazi statunitensi prendono di mira in particolare, e in modo evidente, proprio quelle categorie di beni sui quali la RPC punta di più per realizzare i propri piani economici. Nello specifico – oltre a materie prime come l’alluminio e il rame, che consentono di smaltire le sovrapproduzioni dell’industria pesante – a essere colpiti sono i prodotti di alto livello tecnologico, soprattutto nei settori dell’automazione e delle telecomunicazioni.
Ciò ha già causato delle tangibili conseguenze: a ottobre 2018, la produzione del settore robotica ha registrato un calo del 3% rispetto all’anno precedente, mentre le vendite degli smartphone hanno raggiunto una diminuzione dell’11% nella prima metà dell’anno, confermando sostanzialmente il trend negativo nella seconda.
Le misure protezionistiche dunque colpiscono al cuore gli obiettivi di Made in China 2025, documento di strategia economica pubblicato nel 2015, che legava gli obiettivi della crescita economica alla massimizzazione dello sviluppo tecnologico e al raggiungimento di una posizione di egemonia nel settore.
Pechino ha provato a rispondere inasprendo il suo già collaudato sistema di barriere non tariffarie, ma questo non è bastato ad assorbire il colpo. Consistenti ripercussioni negative, infatti, si sono avute sull’economia cinese nel suo complesso. È vero che nell’ultimo anno le esportazioni hanno raggiunto il picco degli ultimi sette anni, ma ciò è dipeso essenzialmente dalla volontà dei mercati di giocare di anticipo rispetto all’introduzione dei dazi. In realtà, a dicembre l’export è calato dell’1,4% rispetto a novembre e del 4,4% rispetto all’anno precedente, il punto più basso dal 2006. Sempre nel 2018, la crescita del Pil si è ridotta al 6,6%, la performance peggiore addirittura dal 1990.
Se, da un lato, i dati confermano che la strategia americana sta effettivamente riuscendo nell’intento di frenare l’espansione della potenza economica cinese, dall’altro i risultati sulla partita tecnologica sono ad oggi meno definiti. La Cina sta attraversando un momento cruciale, in cui si sta preparando per un cambio di paradigma in ambito tecnologico: dopo avere per decenni riutilizzato tecnologia già esistente – mutuata dalle imprese estere come condizione per la formazione di joint venture – la Cina è attualmente in grado di presentarsi sul mercato internazionale con implementazioni più performanti e a costi più bassi delle soluzioni occidentali. Considerando la possibilità di destinare ingenti capitali al comparto Research&Development (R&D) e la tendenza a imporre propri standard industriali per dominare il mercato interno, non sarebbe improbabile per il futuro uno scenario in cui la potenza asiatica diventasse capace di sviluppare da zero dei nuovi standard tecnologici e di imporli a livello globale.
Lo scenario è in un certo qual modo prefigurato dalla sfida del nuovo sistema di rete 5G, dal momento che i colossi delle telecomunicazioni europei e nordamericani di fatto sono ancora indietro nella fase di sviluppo, mentre l’unico attore veramente pronto per le prossime aste di concessione è proprio Huawei.
Tanto l’arresto della sua direttrice finanziaria quanto i target specifici dei dazi statunitensi dimostrano che al centro dello scontro sino-americano la vera guerra è quella tecnologica. Le infrastrutture per le telecomunicazioni della prossima generazione non solo rappresentano l’occasione di conquistare una posizione egemonica all’interno di un mercato vergine – le aste, per quanto prossime, non sono ancora iniziate – ma chiamano in causa delle questioni strategiche e di sicurezza.
Il fornitore di una rete, infatti, in quanto produttore della sua componente fisica, è nella possibilità materiale di installarvi delle backdoor, ovvero dei sistemi di controllo a remoto in grado di garantire un accesso diretto, eludendo qualunque tipo di protezione applicatavi in una fase successiva. Il controllo delle backdoor è alla base di potenziali attacchi di natura cyber, quali l’estrapolazione di informazioni, il blocco o la degradazione del servizio, l’alterazione nei contenuti o nei metadata.
È proprio facendo leva sull’incertezza legata alla sicurezza della rete che gli Stati Uniti stanno conducendo una campagna intensiva di delegittimazione di Huawei, avanzando esplicitamente il sospetto che il governo della Repubblica Popolare Cinese possa servirsene come “cavallo di Troia” per far breccia nelle reti di sicurezza dei Paesi occidentali.
Le preoccupazioni espresse da Washington si basano su diversi ordini di ragioni. Il primo riguarda la figura del suo fondatore e attuale presidente, Ren Zhengfei. Questi, prima di mettersi a capo di un’azienda privata, ha lavorato per decenni per l’Esercito popolare, sia pure come ingegnere civile. Inoltre, in qualità di leader di un asset strategico quale Huawei, non solo è stato invitato a far parte del comparto economico del Partito Comunista Cinese (PCC), ma è stato successivamente nominato Rappresentante degli Imprenditori. In questo senso, Ren sarebbe una figura legata a doppio filo con il regime.
La seconda motivazione riguarda gli strumenti normativi che il governo di Pechino avrebbe per indurre Huawei a collaborare, impiegando delle backdoor per compiere spionaggio a danno dei Paesi che utilizzano le sue infrastrutture. Effettivamente, l’art. 22 della Counter-Espionage Law del 2014 e l’art. 7 della National Intelligence Law del 2017 prevedono l’obbligo di collaborare con i servizi segreti non solo per gli altri organi dello Stato ma anche per cittadini e imprese private.
La terza ragione è l’assunto che la Cina sia strategicamente ostile agli Stati Uniti e all’Occidente, e tatticamente protesa a fare uso delle nuove tecnologie per carpire i loro segreti e danneggiarli.
Ricorrendo a questi argomenti, negli ultimi mesi l’establishment americano ha esortato tutti i suoi alleati a bandire Huawei dai loro mercati e, in particolar modo, dalle aste di concessione per la fornitura delle reti 5G.
A recepire per primi tale indicazione sono stati gli alleati di Five Eyes, il sodalizio delle intelligence di area anglofona: Australia e Nuova Zelanda hanno già vietato ufficialmente la partecipazione di Huawei alle aste, mentre il Regno Unito ha qualificato la società e i suoi prodotti “non affidabili”, ammettendoli formalmente alle gare ma escludendoli di fatto dalla reale competizione.
Il prossimo passo, per gli Stati Uniti, sarà cercare di portare dalla loro parte i singoli Paesi europei, percorrendo la via dei rapporti bilaterali e ricorrendo a mezzi diplomatici e d’influenza, ma anche a contatti con i vari servizi di sicurezza nazionali: riuscire a costruire una conventio ad excludendum anche nel Vecchio continente vorrebbe dire sottrarre il più grande mercato mondiale all’avanzata tecnologico-commerciale della Cina.