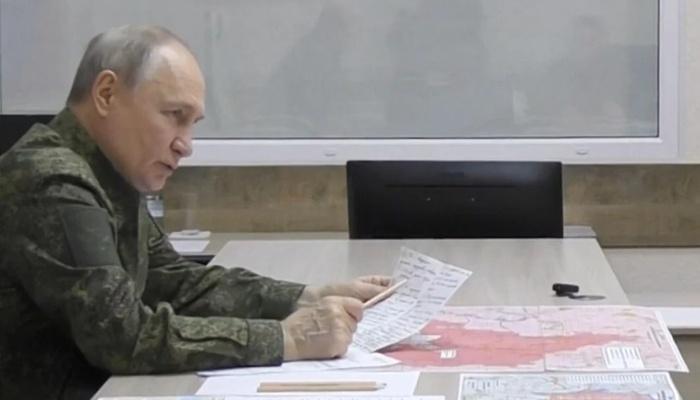L’evoluzione dei requisiti nella difesa delle basi aeree
Gli aeroporti militari rappresentano infrastrutture strategiche per le capacità di deterrenza, difesa e proiezione dello strumento militare aereo, abilitandone non solo il sostegno, ma la stessa efficacia ed efficienza operativa. La rilevanza delle basi aeree le rende da sempre un bersaglio privilegiato e prioritario, comportando specifici accorgimenti e soluzioni adattive volte non solo a proteggere in senso stretto le sole installazioni, ma più ampiamente ad assicurare la resilienza delle flotte. Il riemergere del warfighting convenzionale ad alta intensità quale estremo possibile di un continuum-of-competition di per sé crescentemente caratterizzato da attività ibride, inclusi sabotaggi ed azioni provanti, ha reiterato la vulnerabilità critica di questi obiettivi. La proliferazione presso peer e near-peer competitors, ma anche presso attori asimmetrici, di vettori d’attacco diversificati e sempre più performanti, in grado di penetrare, confondere o saturare le difese aeree alleate, colpendo con elevata precisione e causando danni estensivi al bersaglio rappresenta, infatti, una minaccia significativa ed in costante evoluzione. L’affiancamento a missili balistici e da crociera con caratteristiche tecniche crescentemente avanzate, sia di sistemi ipersonici, sia di droni aerei esplosivi a lungo raggio (OWA UAV – One-Way Attack Unmanned Aerial Vehicle) e di relative piattaforme dalle caratteristiche intermedie complica sensibilmente i requisiti per la protezione di grandi installazioni di alto valore dall’azione cinetica avversaria, anche nella profondità del dispositivo militare alleato. Al di là di uno scenario di conflitto, la diffusione di velivoli senza pilota nelle categorie mini, micro e small, nonché di quadricotteri guidati mediante visore indossabile (FPV UAV – First Person View Unmanned Aerial Vehicle) ha inoltre sensibilmente ampliato le opzioni per la condotta di ricognizioni malevole e di sabotaggi, nonché di azioni terroristiche, contro le pregiate capacità dispiegate presso gli aeroporti militari.
Il conflitto in Ucraina ha plasticamente evidenziato l’evoluzione delle minacce per quanto attiene alle basi aeree, a partire dal massivo bersagliamento delle stesse, anche nella profondità del territorio di Kiev, da parte delle forze russe, mediante un’accurata combinazione di fonti di fuoco multi-dominio. Parallelamente, OWA UAVs ed FPV UAVs sono stati diffusamente impiegati per disabilitare, danneggiare o distruggere al suolo velivoli militari, degradando il potenziale di combattimento nel dominio aereo di ambedue gli schieramenti. Dal 2022, infatti, se il dispositivo militare di Mosca ha messo fuori uso con questi vettori d’attacco almeno un MiG-29 Fulcrum, quattro Su-25 Frogfoot ed un L-39 Albatros, quelle ucraine hanno colpito non meno di 17 velivoli, inclusi due Tu-22M Backfire, un A-50 Mainstay, quattro Il-76 Candid, cinque Su-34 Fullback ed un Su-57 Felon. La distruzione al suolo, anche in basi a grandissima distanza dal fronte di assetti altamente qualitativi, come bombardieri e trasportatori strategici, velivoli di allarme e controllo aereo (AWACS – Airborne Warning and Control System) ed addirittura di piattaforme di quinta generazione, sottolinea la gravità delle nuove minacce poste agli aeroporti militari e del relativo impatto sull’efficacia e resilienza dello stesso strumento militare aereo. Oltre alle lessons identified emergenti dagli eventi bellici est-europei, il sensibile incremento nell’ultimo triennio nelle violazioni dello spazio aereo sopra basi aeronautiche mediante UAVs, spesso senza che gli stessi venissero o potessero essere intercettati o neutralizzati ha evidenziato i rischi posti da eventuali attività di sabotaggio. Gli aeroporti militari di NATO e US Air Force, incluse le installazioni di Lakenheath, Mildenhall e Fitwell nel Regno Unito e quella di Ramstein in Germania sono state nel dettaglio oggetto di una significativa serie di incidenti di questo tipo, i quali hanno sottolineato le rilevanti vulnerabilità a cui sono esposte piattaforme strategiche per la sostenibilità delle capacità militari euro-atlantiche. L’insieme trasformativo di queste criticità e minacce delinea nuovi requisiti operativi e tecnici per garantire non solo la protezione delle infrastrutture aeroportuali militari, ma la stessa conservazione del potenziale di combattimento aereo lungo il continuum-of-competition.
Sotto il profilo dottrinale, il concetto di Agile Combat Employment (ACE), sviluppato dalla US Air Force, sintetizza appieno le esigenze di distribuzione e dispersione del dispositivo militare aereo, e di flessibilità nel supporto a terra e nella logistica di aderenza dettati dal mutato contesto strategico e dai nuovi scenari operativi. Il suo principio cardine è infatti la dispersione delle forze su installazioni più piccole, anziché fare affidamento su un’unica base centralizzata che concentri tutte le risorse. Questo approccio causa una sensibile proliferazione dei potenziali bersagli per l’avversario, generando dilemmi nel ciclo di targeting dello stesso ed implicando un maggiore impegno di risorse per l’individuazione e distruzione degli obiettivi. Secondo l’ACE, il dispiegamento rapido ed agile delle forze è essenziale, con velivoli, equipaggiamenti di supporto e personale che devono essere pronti a riposizionarsi frequentemente, così da rendere più difficile per il nemico determinare luoghi e tempi con cui dispiegare i propri effetti cinetici. Il rischieramento dinamico è strettamente correlato ad adattamenti logistici, quali il preposizionamento di pezzi di ricambio, lubrificanti, carburanti e munizionamento in diverse località, riducendo i tempi di risposta e permettendo agli aeromobili di operare da più postazioni. Oltre ad una profonda evoluzione nella pianificazione logistica delle operazioni aeree, l’ACE comporta anche nuovi requisiti addestrativi per il personale, a cui viene richiesto di predisporre aree di decollo, atterraggio, stazionamento e manutenzione rustiche e di operarle mediante piccoli nuclei. Oltre ad incentrarsi sull’evadere l’individuazione ed il bersagliamento avversari, l’ACE recupera anche l’importanza di capacità di ricostituzione rapida delle infrastrutture di supporto nel caso queste venissero danneggiate da un attacco, incluso con riferimento alla riparazione speditiva delle piste di volo.
In condizioni di rilevante asimmetria capacitiva rispetto all’avversario, ovvero in prossimità del fronte, il concetto di ACE può essere estremizzato in quello della cosiddetta air guerrilla warfare. Integrando una parcellizzazione dinamica del dispositivo militare aereo sul territorio, incluso mediante l’impiego di piste semi-preparate o di idonee reti viarie civili, come autostrade, ed il ricorso a finte postazioni per ingannare l’avversario, questo mira, infatti, a costituire un ambiente operativo in cui l’avversario fatica ad individuare e colpire efficacemente obiettivi di alto valore. Sofisticati velivoli esca (decoys), tanto in volo quanto a terra, così come finte strutture di supporto, combinati con un’accurata azione di camuffamento e guerra elettronica (EW – Electronic Warfare) volti a generare falsi bersagli per il rilevamento multi-sensore nemico rappresentano una componente centrale per confondere, sviare ed inficiare il processo di targeting avversario. Nell’insieme, queste misure permettono di contestare la crescente trasparenza e letalità del campo di battaglia, abilitando il dispositivo aereo quantomeno a contendere la superiorità aerea delle forze contrapposte, conservando al meglio il potenziale di combattimento alleato.
Parallelamente ad un’evoluzione nei requisiti operativi, le sfide poste dalle nuove minacce alla sicurezza degli aeroporti lungo l’intero spettro del continuum-of-competition impongono anche adattamenti infrastrutturali mirati a rafforzare le installazioni, al fine di ridurre l’impatto di un eventuale attacco. Rendere le basi aeree più resilienti comporta infatti l’adozione di hangar in cemento armato, l’impiego all’interno degli stessi sedimi aeroportuali di decoys e la predisposizione di ridondanze capacitive all’interno dei medesimi. Il primario elemento per il cosiddetto hardening è tuttavia la costruzione di hangar corazzati, i quali assicurano una protezione contro schegge, esplosivi trasportati da droni ed in determinate condizioni persino impatti diretti. Sebbene la costruzione di strutture in cemento armato implichi costi elevati, il vantaggio è infatti significativo, comportando un drastico incremento nello sforzo richiesto al nemico per colpire assetti di alto valore e, al contempo, occultano i velivoli dai sistemi di targeting avversari. Dopo le gravi perdite subite nel corso del primo anno e mezzo di conflitto con l’Ucraina e valorizzando le lessons learned derivate, le Forze Aerospaziali russe hanno proprio iniziato a costruire strutture corazzate nelle loro basi più esposte, tra cui Belbek (Sebastopoli), Primorsko-Akhtarsk (Krasnodar) e Millerovo (Rostov). L’Ucraina ha adottato un approccio ancora più drastico, con i suoi F-16 Viper presumibilmente nascosti in bunker sotterranei. Il dispiegamento di decoys, inclusi sagomati di velivoli, finti radar e falsi depositi di carburante, dentro le stesse basi aeree contribuisce ad aumentare indirettamente la protezione degli assetti reali, riducendo la probabilità che questi vengano effettivamente colpiti. Questa tattica è stata sperimentata in modo particolarmente efficace in Ucraina, dove numerosi vettori d’attacco russi hanno centrato falsi bersagli, posizionati per simulare assetti operativi.
Se l’adozione di nuovi approcci dottrinali ed il recupero di alcune soluzioni infrastrutturali contribuisce trasversalmente all’incremento nella resilienza dello strumento militare aereo, la proliferazione di OWA UAVs ed FPV UAVs postula l’adozione di misure di difesa dedicate, complementari ad un’architettura di difesa aerea ed antimissile multilivello per la difesa d’area. La risposta tecnologica può tuttavia assumere diverse forme, suddivise tra sistemi cinetici e non cinetici. Uno degli approcci più esplorati ed a basso costo è rappresentato dalle misure di EW, che includono il jamming delle radiofrequenze e lo spoofing del GPS. Queste tecniche interrompono il collegamento tra un drone ed il suo operatore, neutralizzando quegli UAVs che dipendono da segnali esterni per il controllo. Oltre ad essere economicamente vantaggiosa, l’EW riduce il rischio di danni collaterali, rendendola una soluzione sicura anche in prossimità di abitati civili. Nonostante la sua efficacia, le soluzioni EW presentano alcuni limiti: droni autonomi o semi-autonomi, dotati di intelligenza artificiale, possono operare senza guida esterna, risultando immuni al jamming, mentre UAVs con connessione via cavo eludono del tutto la necessità di segnali radio, rendendo inefficaci le contromisure EW tradizionali. L’esperienza in Ucraina ha evidenziato l’uso crescente di questi droni resilienti, i quali rappresentano una sfida significativa e richiedono soluzioni alternative.
Al fine di affrontare tali vulnerabilità, le armi ad energia diretta, come i laser ad alta energia ed i sistemi a microonde ad alta potenza, integrano crescentemente i sistemi di contrasto agli UAVs (C-UAV – Counter-Unmanned Aerial Vehicle). A differenza degli intercettori cinetici tradizionali, queste tecnologie riducono anch’esse parzialmente il rischio di danni collaterali. Attuali limitazioni tecnologiche ne riducono tuttavia l’efficacia contro sciami (swarms) di droni veloci, ed ulteriori sviluppi saranno necessari prima che possano offrire una difesa su larga scala. Di conseguenza, gli intercettori cinetici rimangono un elemento essenziale della difesa C-UAV. Tra le principali opzioni rientrano missili guidati a corto (SHORAD – Short Range Air Defense) e cortissimo raggio (VSHORAD – Very Short Range Air Defense), munizioni per artiglieria di piccolo e medio calibro programmabili ad esplosione in aria (airburst) ed i droni-contro-drone, ossia UAVs intercettori in grado di neutralizzare le minacce in arrivo.
L’efficace individuazione, designazione, classificazione ed assegnazione alla contromisura più idonea dei sistemi intrusi comporta però l’integrazione di queste soluzioni in un unico apparato capace di sorvegliare e proteggere gli ampi perimetri che contraddistinguono gli aeroporti militari. La fusione di radar, apparati per il rilevamento delle radiofrequenze, telecamere elettro-ottiche, sensori Light Detection and Ranging (LIDAR) ed acustici garantisce infatti una copertura completa, con ogni tecnologia che affronta un aspetto diverso della minaccia. Questo approccio multistrato contribuisce a creare una rete di difesa resiliente, capace di rilevare, tracciare e neutralizzare efficacemente i droni avversari. Rheinmetall produce ad esempio il sistema Skynex, il quale, per abbattere i droni può impiegare l’Oerlikon Revolver Gun Mk3, l’Oerlikon Twin Gun GDF009 TREO, missili superficie-aria, apparati EW sia attivi sia passivi e, in futuro, includerà anche laser ad alta energia. MBDA ha invece concepito il sistema Sky Warden, il quale affronta l’intero spettro di minacce da droni, da quelli nelle categorie micro agli UAVs tattici, fino alle munizioni circuitanti (loitering munitions). Il sistema gestisce l’intera catena di reazione, dal rilevamento alla neutralizzazione, ed è inoltre progettato per funzionare sia come componente integrata in un’architettura di difesa aerea multilivello, sia come configurazione autonoma. Per abbattere i droni, il sistema utilizza jammers, droni cosiddetti cacciatori, laser ed intercettori Mistral 3. Benché la tecnologia dei droni-contro-drone presenti delle criticità in termini di gestione delle segregazioni dello spazio aereo nonché di scalabilità degli ingaggi, la loro proiettabilità ed impiego anche in basi speditive risulta in prospettiva di particolare interesse. Il MORFIUS, sviluppato da Lockheed Martin, rappresenta ad esempio un’alternativa innovativa, costituita da un intercettore riutilizzabile, multi-ingaggio, circuitante e lanciato da tubo, dotato di un seeker a bordo e di un compatto effettore a microonde ad alta potenza per la neutralizzazione non cinetica dei droni, inclusi swarms complessi.
Il persistere dell’importanza pivotale dello strumento militare aereo, in ottica multi-dominio, attraverso l’intero spettro della competizione strategica, dalla deterrenza alla difesa fino alla proiezione di forze, postula la capacità di sostenerne e proteggerne le flotte. Il profondo mutamento delle minacce agli aeroporti militari, ovunque questi siano posizionati, impone dunque esistenziali adattamenti dottrinali e capacitivi, dalle diverse declinazioni del concetto di ACE all’aggiornamento delle infrastrutture aeroportuali attualmente in uso, fino alla riconfigurazione delle difese di punto per affrontare la crescente minaccia ibrida rappresentata dai droni, affinché le Aeronautiche Militari possano sopravvivere per l’eventuale battaglia del domani.