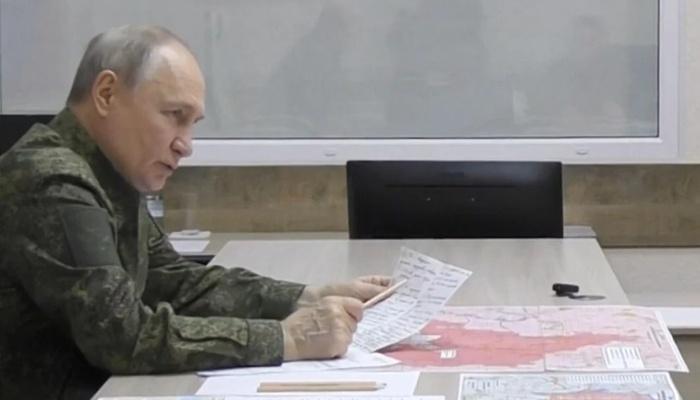La sfida militare sotto i ghiacci dell’Artico
L’Artico è crescentemente un quadrante centrale nelle dinamiche di competizione strategica contemporanee, alla luce delle significative risorse naturali presenti sotto i relativi fondali e della progressiva apertura di potenziali rotte commerciali marittime attraverso i suoi ghiacci per effetto del cambiamento climatico. Nel dettaglio, si stima le profondità artiche presentino depositi di idrocarburi in grado di generare fino a 90 miliardi di barili di petrolio grezzo e corrispondenti al 30% delle riserve globali di gas naturale. Al contempo, il progressivo incremento dei periodi di accessibilità ai corridoi tra i ghiacci presenta il potenziale per trasformare le dinamiche di connettività via nave dell’intero emisfero boreale, in particolare tra Oceano Pacifico ed Atlantico. L’accesso preferenziale ed il controllo dei giacimenti, così come delle emergenti linee di comunicazione marittime (SLOC – Sea Lines of Communication) nell’Artico è dunque alla base di una ripresa nella sfida tecnologico-capacitiva multi-dominio per la superiorità militare nella regione, la quale include in modo preminente anche il (quasi) dominio sottomarino.
L’interesse per le operazioni subacquee in Artico trova propriamente avvio durante la Guerra Fredda, quando sia gli Stati Uniti d’America, sia l’Unione Sovietica esplorarono in una serie di spedizioni successive la possibilità di navigare e manovrare sotto i gelidi ghiacci polari. Gli Stati Uniti furono i primi a raggiungere il Polo Nord con un sottomarino, quando lo USS Nautilus, il primo battello a propulsione nucleare (SSN) nella storia, navigò sotto la calotta artica il 3 Agosto 1958. Nel 1959, lo USS Skate divenne invece il primo sottomarino ad emergere attraverso la banchisa, in prossimità del Polo Nord, nel contesto di una campagna navale di numerosi giorni nella regione. L’Unione Sovietica raggiunse i medesimi traguardi nel 1962, con il K-3 Leninsky Komsomol, classe November, il primo SSN sovietico, che dopo aver navigato in immersione sotto l’Artico penetrò la banchisa vicino al Polo Nord. L’incedere della Guerra Fredda e lo sviluppo di sottomarini nucleari per il lancio di missili da crociera (SSGN) e balistici (SSBN) resero ancora più rilevante l’Artico, in particolare sotto il profilo della deterrenza strategica, con lo scenario di un SSBN, statunitense o sovietico, occultato sotto i ghiacci e pronto ad emergere, in prossimità rispettivamente delle coste artiche russe o nord americane, per rilasciare un attacco nucleare senza preavviso ad inquietare per decenni i comandi militari delle due superpotenze.
Al fine di consolidare le rispettive capacità operative sottomarine nel quadrante, durante l’intero periodo bipolare si registrarono reiterate attività ed esercitazioni dedicate da parte delle flotte di Mosca e Washington. In particolare, nel 1971, lo USS Queenfish e lo USS Pargo, due SSN classe Sturgeon, presero parte al primo Ice Exercise (ICEX), a cui sarebbero seguite al 2022 altre 98 iterazioni coinvolgenti battelli della Submarine Force della US Navy. Analogamente, anche la flotta sovietica condusse periodiche operazioni sotto la banchisa, sperimentando l’efficacia in un ambiente operativo così altamente sfidante i nuovi battelli sviluppati, a partire dal 1972 con il K-222 classe Papa, al 1981, con i K-524 e K-206 delle classi Victor I e II. La Marina Militare di Mosca valorizzò inoltre i vantaggi derivanti dalla difficoltà di tracciare i sottomarini sotto la calotta artica anche in una serie di attività addestrative volte a simulare un eventuale attacco contro gli Stati Uniti, impiegando la banchisa come via d’accesso furtiva all’Atlantico occidentale nelle Operazioni Aport e Atrina. L’aggiramento della Groenlandia sotto i ghiacci artici permetteva infatti ai battelli sovietici di evitare l’identificazione da parte NATO attraverso la linea di sensori Sound Surveillance System (SOSUS) posizionata nel Greenland–Iceland–United Kingdom Gap (GIUK Gap), principale SLOC di accesso all’Atlantico per le unità navali della Flotta del Nord.
Dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, la competizione militare per l’Artico, incluso nel (quasi) dominio sottomarino, registrò una temporanea riduzione, seguita tuttavia, in particolare nell’ultimo decennio, da una ripresa dell’interesse per la regione, in parte collegato al menzionato incremento nell’accessibilità alle risorse naturali ed alle rotte marittime nel quadrante, in ambedue i casi favorito dal cambiamento climatico ed in parte dal riaffermarsi di un confronto strategico pervasivo. La Federazione Russa ha infatti provveduto ad accrescere sensibilmente le proprie capacità operative in Artico, combinando lo sviluppo di un vasto network di basi militari e di siti dual-use per la proiezione nella regione, la periodica condotta di esercitazioni dedicate e la frequente sperimentazione e validazione di mezzi, materiali e sistemi d’arma nel quadrante. Trasversale a tutti i domini ed a ciascuna delle component delle Forze Armate russe, l’addestramento ed approntamento ha riguardato anche le attività sotto la superficie dei mari artici e sotto la calotta polare, coinvolgendo anche i più moderni SSBN classe Borei ed SSGN classe Yasen, entrati in servizio nella flotta di Mosca rispettivamente dal 2013 e dal 2014. Nel 2021, durante l’esercitazione Umka-2021, proprio un classe Borei, insieme a due SSBN Delta IV emersero simultaneamente attraverso il ghiaccio artico, interrompendo un periodo in cui non era stata praticata questa tipologia di attività che durava dal 1996 per la Marina Militare russa.
Analogamente, anche la US Navy ha mantenuto ed affinato la capacità di operare sottomarini in Artico, incluso attraverso il dedicato Arctic Submarine Laboratory e mediante la condotta biennale delle esercitazioni ICEX, le quali hanno sistematicamente coinvolto SSN classe Seawolf, Los Angeles e Virginia. Durante una di queste, nel 2018, lo USS Connecticut, classe Seawolf, lo USS Hartford, classe Los Angeles, e l’HMS Trenchant, classe Trafalgar della Royal Navy, effettuarono un’emersione coordinata attraverso la banchisa polare. Le manovre sottomarine della US Navy nel quadrante, aumentate nel corso dell’ultimo decennio, hanno inoltre teso a coinvolgere crescentemente gli assetti di Alleati NATO, soprattutto di quelli di Paesi affacciantisi sulla regione. Queste hanno riguardato non solo l’impiego di battelli sotto la superficie, ma con il rafforzamento della postura militare russa in Artico hanno teso a porre una significativa attenzione anche sulle opposte capacità di lotta antisommergibile (ASW – Anti-Submarine Warfare). Le periodiche esercitazioni Cold Response e Dynamic Mongoose hanno rappresentato infatti i primari eventi addestrativi specificatamente intesi allo scopo.
In merito ai battelli in grado invece di contribuire a manovre sotto la calotta artica, fatta eccezione per la Royal Navy e la Marine Nationale, le flotte degli altri alleati atlantici non dispongono di sottomarini a propulsione nucleare, comportando criticità non marginali per la pianificazione e condotta di questo tipo di operazioni. I battelli diesel-elettrici (SSK), se privi di specifici accorgimenti, possono infatti incorrere in problematiche nel bilanciamento termico in conseguenza delle gelide acque, con impatti sull’efficienza della piattaforma, e presentano un tempo di permanenza in totale immersione ridotto rispetto a quello di un SSN. Sia i classe Victoria della Royal Canadian Navy, sia i classe Ula della Royal Norwegian Navy presentano tuttavia la capacità di operare nel dominio marittimo artico, in prevalenza ai margini della calotta polare (MIZ – Marginal Ice Zone). La condivisione di requisiti tecnici ed operativi, nonché delle lessons learned tra questi e gli Alleati ha contribuito poi ad abilitare la condotta di attività artiche sottomarine anche da parte di altre Marine Militari della NATO, incluso, all’inizio del 2024, da parte di un SSK classe Tridente dell’Armada Portuguesa, il quale ha effettuato un pattugliamento sia nella MIZ, sia a tratti sotto la banchisa.
Il consolidarsi della competizione strategica nell’Artico delinea dunque crescenti esigenze capacitive anche nel (quasi) dominio sottomarino, dalle peculiari caratteristiche ambientali, della regione. Le bassissime temperature dell’acqua, l’impossibilità di emergere se non attraverso metri di ghiaccio una volta in navigazione sotto la calotta polare e le specificità dello spettro acustico nell’area, influenzato da temperatura e densità dell’acqua, ma anche dal persistente rumore causato dal fratturarsi della calotta polare, pongono sfide tecnologiche sostanziali. Il controllo però degli abissi artici e dell’Artico dagli abissi rappresenta tuttavia un abilitante centrale per la superiorità militare in un quadrante sempre più contestato e conteso.